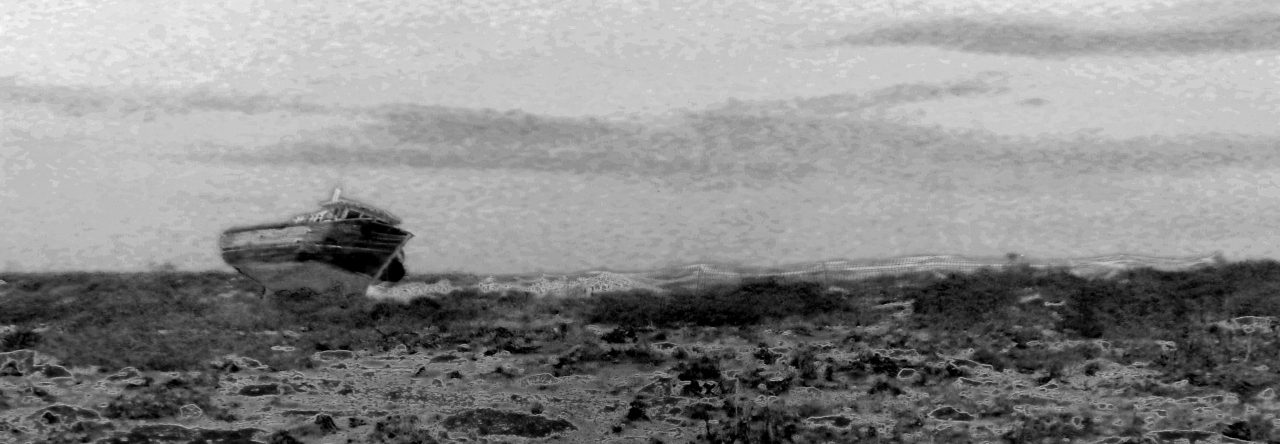Premessa
Alla fine di febbraio sono stata coinvolta nuovamente in un viaggio proposto dall’ ADL per monitorare i movimenti migratori sulla Rotta Balcanica e proseguire il report ‘‘No man’s land’’. Siamo partiti in cinque da Torino. Maria Perino, Piero Gorza, William Bonapace, Enrico Carpegna ed io. Sono la più giovane e la più inesperta nella ricerca. Siamo un gruppo eterogeneo per competenze ed approcci: tre professori, di cui due antropologi ed una sociologa, un fotografo ed una studentessa. Ognuno di noi, attraverso esperienze diverse, ha sviluppato negli anni un legame informato con la Bosnia che ha portato ad avere competenze profonde, sguardi accorti e prospettive attente riguardo a quella terra. Per questo ritengo che il nostro approccio cerchi di differenziarsi da quello che, nell’esotismo di frontiere lontane da casa, va cercando solo il dramma di una realtà più complessa di ciò che appare.
Sono convinta che, nonostante i limiti di questo viaggio, faremo il possibile per muoverci nel modo più delicato ed utile. In questa ‘‘spedizione’’ il tempo è estremamente limitato, abbiamo solo tre giorni effettivi. I cambiamenti che riguardano la Rotta avvengono in modo precipitoso e veloce a tutti i livelli, questi ultimi sono tanti ed intersecati tra loro. L’epidemia di CoVid-19 comincia a riempire i discorsi delle radio e dei giornali mentre noi andiamo verso Est, e ancora non sappiamo che spazio dare al fenomeno nelle nostre analisi. Monitorare una situazione costretta a rimanere confusa ed irregolare non è facile. Riuscire a contattare il maggior numero di realtà attive sul territorio per poter avere un chiaro schema della situazione è frustrante e faticoso. Il tempo gioca a sfavore. Raccogliere dati è un compito difficile soprattutto in situazioni dove l’umanità è fortemente messa in discussione se non cancellata. Descrivere la complessità della situazione senza trascurare l’importanza di un contesto complicato, come quello della Bosnia Erzegovina, è decismente impegnativo. Anche se sono consapevole della nostra esperienza ho comunque delle riserve su questa partenza. Data la breve permanenza sul campo temo di sentirmi una ladra di storie senza poter lasciare nulla di concreto ma solo la speranza di poter raccontare. Mi sembra di prendermi il privilegio di tuffarmi nella miseria ma con la possibilità di saltarne fuori discretamente serena dopo poche ore, al massimo giorni. Con queste
immersioni lampo sento il rischio di contribuire in un certo modo alla disumanizzazione generata da questa situazione.
Nello scorso viaggio, intrapreso a luglio, siamo stati nel bosco alla frontiera con la Croazia sopra Bihać. In quella situazione abbiamo incontrato una famiglia di Idlib che, nella veranda di un vecchio rifugio diroccato, aspettava di attraversare il confine. Il padre ci aveva raccontato con parole arabe, inglesi e gesti parte della loro storia. L’incontro si era concluso con un mio scatto di una fotografia di famiglia, mi sono sentita profondamente spudorata e immeritevole della testimonianza di quell’unione. Sulla strada del ritorno, per la prima volta, non avevo risposte da dare a me stessa, non avevo toni e colori da attribuire a quell’emozione, a quell’evento. Ho paura di non saper-mi spiegare.
Scrivendo temo di concorrere all’oggettivazione della macro categoria ‘‘migranti’’.
Più volte, mentre battevo queste parole, non sapevo quali termini usare per mettere in evidenza la consistenza umana di chi affronta la migrazione. Migrante, profugo, rifugiato sono parole che costringono in categorie giuridiche e in questo caso a me sembrano vuote. Di fatto ho incontrato professori, studenti, uomini, ragazzini, ottimisti, pazzi, fumatori…la soggettività ‘‘migrante’’ è solo una delle molte sfaccettature di queste persone.
In questo breve racconto ho deciso di adottare una prospettiva soggettiva, la mia, poichè è quella che ha necessitato di più lavoro per essere portata alla luce.
Se è facile descrivere la decadenza di quella situazione non lo è altrettanto restituire cosa si riesce, e non si riesce, a pensare in quei momenti.
Mi sono sentita cinica, ho sentito il bisogno di mettere in sordina l’empatia, di mettere da parte la mia incredulità e lo straniamento che tutto questo mi ha suscitato. Mi scuso se alcune mie considerazioni possono essere pietiste ed altre fredde ma mi è difficile esprimere con chiarezza queste sensazioni fatte, per lo più, dell’assenza di un’emozione lessicalmente connotata. Non me ne voglia chi lavora in situazioni difficili da anni e chi riesce a scindere analisi scientifica da emotiva, non me ne voglia chi pensa che non abbia avuto il coraggio di andare più a fondo di così.
Velika Kladuša
Ci troviamo in Bosnia nord occidentale –Krajina– terra di confine. La storia di questa città ha un posto di spicco in molte tappe del tempo, i suoi attori e le loro imprese sono ancora più interessanti. Si potrebbe addirittura cominciare dagli anni’50, quando è stata uno dei teatri della rivolta contadina di Cazin contro la Repubblica Federale. La città apparteneva ad una delle aree più povere della Bosnia fino agli anni ’70, quando entra in scena un importante, e piuttosto bieco, personaggio: Fikret Abdić. Egli diventa proprietario dell’Agrokomerc a Velika Kladuša: prima piccola coopertiva, poi industria agro-alimentare.
Sotto la guida di Abdić questo stabilimento industriale, anzi colosso, raggiunge il suo apice: 13.000 impiegati, servizi a tutto tondo per la città, sviluppo locale e beneficio economico all’intera Repubblica. Velika Kladuša diventa una delle città più ricche di Bosnia, tanto da essere chiamata «la Svizzera jugoslava ». Il suo proprietario assume una celebrità ed un’importanza che vanno oltre i confini della città, dove lo chiamano « Babo » (papà) – un vero e proprio signorotto locale, arrivando fino all’impegno in politica.
Negli anni ’80 l’Agrokomerc si trova al centro di uno scandalo finanaziario, Abdić viene sollevato da diverse cariche e mandato in carcere, uscirà in tempo per giocare le sue carte durante il conflitto.
Nel 1990 Babo, libero, si candida alle prime elezioni libere della Bosnia con l’SDA, lo stesso partito di Izetbegović. Durante il conflitto riesce a suscitare le simpatie di Croati-bosniaci, Serbi-bosniaci e Comunità Internazionle, in particolare l’UNPROFOR. Il continuo scontro tra gli interessi di Abdić per il suo feudo (lontani dal nazionalismo) e quelli politici portano, in quell’area, alla guerra civile tra bosgnacchi nella guerra civile stessa.
Nel 1993 Fikret Abdić fonda la Provincia Autonoma della Bosnia Occidentale, di cui si proclama presidente. Attraverso le spoglie di Agrokomerc gestisce contrabbando e controllo dei convogli umanitari. Nel frattempo il suo esercito sparge violenza sulla sua stessa gente e si occupa di combattere le forze governative di Sarajevo che lo sconfiggono definitavemente, dopo diversi tentativi, nell’estate del 1995.
Abdić si rifugia in Croazia. Dal 2002 affronta un altro periodo in carcere da cui esce nel 2016 e fonda un partito suo che governa a Velika Kladuša fino al 2012.
A vent’anni dal conflitto la ‘‘città del miracolo economico’’ diventa, come molte in Bosnia, città svuotata dalle crisi: quella del dopo guerra e quella delle privatizzazioni.
Un luogo, oggi parte dell’entità della Federazione di Bosnia Erzegovina, che ha già una storia complicata e contorta a livello politico economico e sociale, per non dire ‘‘intra-etnico’’. Ma le sue contraddittorie ‘‘meraviglie’’ non finiscono qui: da quando la Rotta Balcanica ha cominciato a battere sentiero anche nella zona nord occidentale della Bosnia, Velika, data la sua prossimità con il confine croato, diventa uno dei luoghi più attraversati dai migranti.
Inizialmente si sono costituiti accampamenti informali. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) dal primo novembre del 2018 vi ha stabilito uno dei suoi Transitory Reception Centers (TRC), affittando parte di uno stabilimento industriale, il Miral. Ciò non ha risolto la situazione. Alcune associazioni nazionali ed internazionali cercano di mettere ‘‘una toppa’’ ad una questione estremamente complicata e mutevole, con scarsi risultati.
Le istituzioni (governative ed internazionali) sono iperburocratizzate, ridondanti, in concorrenza tra loro e spesso caratterizzate da disfunzionalità e irresponsabilità. Dall’inizio di questa emergenza i volontari, stranieri e non, sono costantemente ostacolati nel loro lavoro a causa di restrizioni del governo e di atti violenti da parte di gruppi anti-migranti legati ai movimenti nazionalisti.
L’assenteismo di un governo centrale, la scarsità di misure adeguate, e la facilità dei traffici illegali nell’ inserirsi in queste maglie rendono la situazione ancora più complessa.
Il 21 febbraio arriviamo direttamente da Trieste a Velika Kladuša dopo un lungo viaggio. Per me è la seconda volta che passo da questa città, le differenze della stagione si uniscono alle cose che posso osservare meglio. Anche se, in realtà, non ho mai avuto la possibilità di vedere la città in modo completo. Lo spazio di azione che abbiamo sempre occupato è limitato alla zona vicino alla moschea, un ristorante, la taverna solidale e il punto di soccorso adiacente, due strade e poco più. Questa volta ci interesserebbe osservare ciò che accade in uno squat.
Era nostra intenzione poter accedere al campo dell’IOM Miral ma le “visite” sono precluse nel fine settimana. Ci recheremo tra qualche giorno a Bihać nel TRC Bira affrontando una serie di scoraggianti profilassi burocratiche (invio di mail, nomi, passaporti, orari). Saremo gentilmente affiancanti da un ossequioso membro del personale, il quale, dietro alla mascherina, provvederà a raccontare tutto quello che possiamo (e non ciò che vogliamo) sapere sul campo.
Passando in macchina attraverso la città sembra che Velika Kladuša sia il paese con più Frizerski salon (parruchieri) di tutta la Bosnia. Apparentemente la diaspora, rientrata in patria, mette su piccole attività imprenditoriali come negozietti e ristoranti simil-eleganti. Alcuni di essi, non ancora sperimentati, hanno nomi italiani. Nel raggio di pochi metri c’è il Granvolta, il Barbarosa, ed il Toscana esattamente di fronte a dove parcheggiamo.
Sono le due del pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo. Per strada c’è poca gente, quà e là passeggiano persone che si nota facilmente non essere bosniache.
Abbiamo appuntamento con dei volontari italiani al Napoleon, nome non poco enfatico. Si tratta di un ristorante dall’eleganza kitch un po’ raffazzonata (ma ottimo cibo) con un ampliamento prefabbricato sotto il quale anche il sole di febbraio produce un effetto serra in cui si potrebbero coltivare i pomodori. Questa estate il dehors era pieno di tavoli, con ombrelloni pubblicitari della Ozujsko (una birra croata). Adesso che è inverno, sebbene dalle temperature non si direbbe, il dehors vuoto porta ancora i segni delle feste di Natale, ormai finite da mesi. Le decorazioni impolverate e sbiadite ci tengono compagnia durante una solitaria sigaretta di fine viaggio.
Il nostro appuntamento, a quanto pare vittima di un’incomprensione, è saltato.
Occupiamo il primo tavolo alla destra dell’ingresso, vista strada, così tra un ordine e l’altro continuiamo ad osservare il via vai di gruppetti di migranti.
Davanti all’ingresso si ferma un ragazzino bosniaco in cerca di soldi. Sia gente dal ristorante che migranti in passaggio gli lasciano un po’ di cibo e qualche monetina.
Questo momento, che ha poco di straordinario ed è un qualcosa che succede in modo simile anche in Italia, alimenta due considerazioni già affrontate in altri ambiti. La prima è che uno dei problemi della Bosnia è legato alle condizioni economiche del paese stesso dove, insieme a molto altro, manca un sostegno sociale istituzionale per chi vive le conseguenze di vent’anni di privatizzazioni predatorie e politiche clientelari. In questo vacuum di alternative si inserisce, come una freccia, la Rotta Balcanica. La seconda riflessione è che, a fare fronte a quell’assenza c’è a volte la popolazione non solo locale ma anche individui esterni.
La Taverna Teferić
Finiamo di mangiare e ci dirigiamo verso la taverna/pizzeria Teferić che si trova poco distante. Affianco vi era anche in un punto di soccorso, che a febbraio sembra chiuso, ed un free-shop.
Da due anni a questa parte il proprietario, con alcuni finanziamenti esterni e l’aiuto di associazioni, ha cominciato a distribuire pasti gratuiti ai migranti. In seguito la taverna è rimasta chiusa per un po’ di tempo e adesso, la gestione è passata a un signore montenegrino e ad un iraniano ungherese mi spiega Maria.
Ora il ristorante si chiama Asia, ha il menù in arabo poggiato fuori dalla porta.
Nel dehors ci sono circa una decina di uomini, alcuni di loro ci accolgono con un ironico sorriso, per niente stupito di vederci. Si comincia a chiacchierare. Da dove veniamo, da dove vengono alcuni di questi ragazzi. Algeria e Marocco sono le provenienze più diffuse in quel gruppo.
Hanno provato il game? Lo riproveranno? Dove stanno? Che cosa facevano prima di partire? Da quanto tempo sono qui? Perchè sono partiti? Non si fanno solo discorsi seri, c’è del sarcasmo diffuso nelle risposte sul perchè loro si trovano a Kladuša: «beviamo il caffè», «siamo in vacanza !».
Deve essere, in effetti, amara abitudine che di giorno in giorno passino alla taverna volontari, internazionali e giornalisti che pongono le stesse domande e cercano storie, ma la situazione non si sblocca.
I ragazzi sono la meta di una curiosità, a volte pietista e malsana, per raccogliere il racconto di un pushback, a volte ricambiando beni che possano essere loro d’aiuto.
In questi rapidi transiti di interessati avventori mi chiedo cosa si costruisca dell’Altro.
Alla curiosità di questo pellegrinaggio rispondono le strategie di chi vive nel limbo del confine. Le storie che si raccontano diventano riscatto, scambio e quindi azione per non essere più vittime ma anche attori.
Dopo alcuni istanti si avvicina anche Hamid, occhi di ghiaccio. Si presenta: Algerino, kabyl, 29 anni, laureato in informatica. Parla francese, potrebbe tranquillamente essere un mio compagno di università di quando stavo a Parigi.
I suoi discorsi spaziano dalla letteratura alla filosofia (ad un certo punto cita Descartes). Io mi introduco come studentessa e attivista. In modo estremo e calcato, sull’onda di un entusiasmo romantico che spesso si fa largo nelle mie idee, esprimo al mio nuovo amico che, se fosse per me, questa situazione si dovrebbe risolvere col fuoco: sull’Europa, sulle frontiere. Hamid rimette il mio slancio ideologico subito al suo posto. La sua preoccupazione principale non è la frontiera né l’impossibilità di attraversarla. Anche se chiaramente reputa tutto ciò un’assurdità, la sua domanda è molto più mirata: «siete giornalisti? Lavorate per un’ONG? Sapete se esiste un’ONG che può raccontare la violenza che subiamo all’Europa di modo che qualcosa cambi?».
Ribadisce spesso: «io non sono un criminale, non sono un terrorista, né uno spacciatore, né un passeur. Sono laureato in informatica. Se alla frontiera vengo fermato alzo le mani, quello che non capisco è perché io debba venire picchiato, insultato, mi si venga tolto il telefono, i vestiti e debba essere buttato nel fiume».
Continua: «Noi qui viviamo come gli animali, anche peggio, se volete vi posso portare in un campo, occupato “anarchicamente” da noi, algerini e marocchini».
Sebbene sembri pianificato, razionale e un po’ bieco, il nostro obbiettivo era proprio quello di trovare lì un contatto per raggiungere il campo informale di cui avevamo solo poche indicazioni satellitari. Hamid ci mette in guardia: «Potrebbe essere scioccante, è davvero una brutta situazione, ma potrebbe servirvi per raccontare quello che succede qui, in quell’Europa dove si insegnano i diritti umani» conclude ironicamente.
Ci mettiamo pochi secondi per consultarci e decidere come spostarci, poi ci avviamo guidati dal nostro nuovo contatto ed altri due ragazzi poco più giovani e un po’ più silenziosi.
Camminiamo come se fosse una passeggiata al sole invernale e intanto parliamo, incrociamo altri ragazzi che arrivano dallo squat e vanno in città per comprare farmaci, andare a mangiare, forse farsi una preziosissima doccia pubblica a prezzi che corrispondono quasi a quelli di una spa (5 euro). Molti di loro ricevono soldi dalla famiglia, altri intraprendono piccoli commerci informali di sopravvivenza. In città non c’è intenzione ad assumere stranieri, neanche in nero, ci racconta un giovane algerino sulla ventina.
«Si cammina sempre…» dice Hamid. Il percorso verso l’Europa, spiegano, “inizia” a piedi dalla Bosnia nord-occidentale, con una media di 30 kilometri al giorno, si cerca di arrivare a Zagabria (82km di distanza). Da lì, l’obbiettivo è quello di prendere un bus che faccia arrivare in Slovenia e poi in Italia e così via, oppure si prosegue a piedi per diversi giorni, cercando di beffare il controllo assiduo delle polizie di frontiera. Coloro che intendono prendere i mezzi pubblici trovano modo di camuffarsi da turisti attraverso i vestiti e i gesti. L’oggetto più ricercato per questo viaggio sono ovviamente gli zaini. Anche Farid, che cammina affianco a me, mi fa presente questa cosa indicando con occhi attenti il mio north face nero. La polizia alla frontiera li sequestra insieme a tutto il resto.
Molti di coloro che vogliono passare il confine non riescono ad ottenere i documenti necessari per entrare nei campi dell’IOM oppure hanno perso la possibilità di starci dopo aver provato l’ennesimo game. Altri ancora, forse la maggioranza, preferiscono sottrarsi alle misure di controllo e disumanizzazione dei campi istituzionali, quindi cercano riparo in case abbandonate e in costruzione o in altri spazi.
Hamid, Farid e un altro ragazzo ci stanno portando nel loro “rifugio” in cui la maggior parte sono algerini, kabyl e marocchini.
Polije
Il campo è lontano dalla città. William ci raggiunge con l’auto e compie diversi viaggi per arrivarci più velocemente. Arriva anche il mio turno. Quando salgo in macchina William informa: «la situazione lì, è drammatica, oggi sarà difficile».
Nella mia testa comincia a farsi spazio un traffico di pensieri a metà tra l’auto-rassicurazione –queste situazioni vanno affrontate e sono più comuni di quanto si pensi (purtroppo)– e la concentrazione –apri gli occhi, guarda osserva, ascolta, cogli i dettagli.
Il campo informale “abitato” da circa 150 uomini, in età compresa tra i venti e i cinquant’anni, si trova in una fabbrica dismessa che porta il nome di “Kendić Promet”, nella frazione di Polije. Il luogo non è completamente abbandonato, attorno c’è movimento di mezzi e gente al lavoro.
Maria ed io facciamo ancora un giro di macchina per recuperare Piero. In realtà decido di accompagnare Maria perché avverto uno strano timore per quello che osserveremo. Mi sembra necessario aspettare ancora pochi minuti per passare dalle chiacchiere al momento in cui presumo che non avrò risposte per me stessa. Intanto Maria detta alcune note da segnare sul quaderno.
Quando scendo dall’auto mi colpisce quanto quello spazio sia per macchine e non per uomini: la fabbrica ed il suo ingresso grande, con varchi da automezzi e, lì sotto, gruppetti di persone. Al cospetto di una struttura tanto enorme queste sono piccole.
Cerco Hamid con lo sguardo. Credo di essergli simpatica. Non capisco se ha davvero premura che quella situazione possa turbarmi, o se vuole testare lo sgomento della ‘‘ragazzina europea idealista’’ che pensa di farci qualcosa con le storie di cui si sta riempendo gli occhi. Mi fido comunque di lui, come di un amico più grande, cerco e ascolto le sue parole attente da cicerone della miseria, ma tendo ad evitare le sue domande. Con tutti questi timori, mi avvicino con Maria ad un primo gruppo di circa sei ragazzi. Sono pur sempre una donna, giovane, in mezzo a un sacco di uomini e, non per essere maliziosa, ma qualcuno ammicca proprio.
Insomma, prima viene il mio essere donna e dopo l’essere osservatrice. Ciò mi infastidisce un po’ ma non mi sento in pericolo.
Un ragazzo sulla trentina si sbottona i pantaloni dicendo «guarda!». Vedo ambiguità in questo gesto, lo guardo negli occhi: «Oh ma che cazzo fai?» dico in italiano. Un altro ragazzo mi redarguisce con un gesto della mano come per dire: «Bella, qua nessuno si mette in mutande per te», mi tranquillizzo, forse non devo sentirmi presa in causa in questo modo.
Adesso si, capisco perché quell’uomo si è sbottonato i pantaloni: grandi lividi, di quelli che presentano diversi colori nei loro contorni di manganello di frontiera, rigano le sue cosce. Ecco cosa mi voleva mostrare. Forse anche si, con scherno. Lo fa subito, come prima interazione, come se sapesse che io cerco quell’immagine.
Non c’è da negare che siamo lì per osservare anche questo.
Eppure vorrei che qualcuno non dovesse mettersi in mutande davanti a sconosciuti vivendo, forse, una certa umiliazione per doverne raccontare una ancora più grande.
Comincia un altro vortice di pensieri: io, noi, quest’oggi, siamo persone, tra tante, che raccolgono, o forse rubano, le storie, se le comprano in cambio di un po’ di ascolto e un pacchetto di sigarette.
I ragazzi di questo squat, ridotti ad animali in uno zoo mediatico, ci vendono esattamente il prodotto che cerchiamo: la violenza cruda sui corpi da quel giaciglio di amianto e fango.
E così, tra un «where are you from» e «what are you doing here», ci raccontano chi sono, perché sono lì, del loro viaggio fino a quel momento, del quotidiano che vivono così assurdo per essere chiamato tale e dei pushback della Croazia.
Non si capisce se il respingimento avvenga per tutti secondo la stessa prassi, come se fosse una storia imparata a memoria da raccontare, oppure se vi sia una struttura di pratiche della violenza su chi tenta di passare il confine, suddivise per fasi, senza lasciare nulla al caso. Inizialmente sembra che chi esegue i pestaggi non sia della polizia, alcuni raccontano di gente con passamontagna nero, manganello e divisa blu, altri di divise verdi, altri ancora di uomini in passamontagna ma con uniformi dove vi sono le scritte “Polizia” e “Croazia”.
I momenti del respingimento alla frontiera sono definiti e cronologicamente articolati: ritiro del telefono cellulare o rottura (in base alla qualità del dispositivo), pestaggio, requisizione di scarpe, vestiti e zaini, spinta in qualche corso d’acqua nei pressi del ritrovamento. Alcuni raccontano anche di essere stati denudati.
Insomma, concludo sintetica ed oggettiva tra me e me, un’umiliazione come se la parola bastasse a cristallizzare nella mia memoria cosa ricordare, cosa no, e come analizzarlo.
Bienvenu
Hamid ricompare e chiede se entriamo. Ci da il benvenuto. Gli dispiace non avere cibo per accoglierci, che gentile e cinica ironia. Ancora mi bombarda di avvertimenti: «sarà un bel colpo, è scioccante, mi raccomando non ti scandalizzare». Con un po’ fastidio mi chiedo ancora cosa voglia: il mio turbamento? Più la sua involontaria supponenza cerca una mia risposta emotiva più si rinforza il mio tentativo, abbastanza inutile, di costruire un filtro tra ciò che vedo e ciò che provo.
Nel grande capannone è tutto offuscato di fumo, ci sono tende da campeggio sparse e consumate, sistemate disordinatamente, i loro colori mi ricollegano ai campeggi dei festival e lì sembrano quasi fuori luogo.
Attorno ad un fuoco, alimentato da qualcosa che produce un odore chimico, ci sono vecchi divani e sedili recuperati. Su questi resti di arredamento da discarica sono seduti dei ragazzi che, presumo, cerchino di far scorrere il tempo e scaldano dell’acqua filtrandola con una maglietta. Al vederci, anche loro, ridacchiano.
Questi sorrisi, resi quasi ghigni, da una situazione che difficilmente scaturisce un sorriso disteso mi inquietano, eppure non posso dire di trovarli inopportuni.
Non riesco a capire come, e se, sia strutturato lo spazio, se vi sia una zona per dormire, una per mangiare…un ordine del vivere dentro questo abitare invisibile. Credo che l’ultimo interesse di questi ragazzi sia lo sbizzarrirsi nell’arredamento interni, però sarei curiosa di sapere come avviene questa “autogestione”, lontana, per necessità diverse, dal concetto che ho di “spazio occupato”.
Tutto si alterna a torrette di copertoni, mucchi di polvere rossiccia, tubi e detriti. La luce batte contro i mulinelli di fumo e polvere entrando dai telai precari delle grandi finestre senza vetri. I soffitti sono alti e nel mezzo del capannone corre una fila di pilastri con ancora tracce di colori memori di essere stati vivaci. La spazzatura è ovunque: macerie quà e là, pacchi di patatine aperti fino agli angoli, vestiti abbandonati, biscotti, oggetti, tutto circondato e intriso di polvere.
Non ho il coraggio di muovermi in quello spazio, non riesco ad andare più in là di alcuni metri rispetto a dove mi trovo, come se avessi paura di andare oltre, di invadere qualcosa di riservato.
Mi vergogno a buttare la sigaretta per terra, dopo tutto sono ospite dove qualcuno ci vive, e mi sembra tanto assurdo questo ragionamento.
Su una tenda un cucciolo di cane dormicchia, come se fosse sua.
Poco a poco che mi sposto, attorno a me si radunano dei ragazzi e perdo completamente di vista i miei compagni di viaggio.
Un ragazzino con la giacca rossa troppo larga ed un cappellino blu sistemato in modo buffo si avvicina a me. La domanda con la quale si presenta mi mette in crisi: «Siete un ONG, dei ricercatori, dei giornalisti? Cosa ne farete delle nostre storie?». Lo guardo un po’ indispettita, mi prendo alcuni secondi per riflettere e temporeggio.
Provo ad interpretare la domanda: teme forse che potremmo metterlo in pericolo? Rispondo: «io in realtà non sono nessuna delle tre, sono un’attivista e una studentessa. Quello che raccoglieremo delle storie di oggi verrà inserito in un report sulla situazione dei migranti in Bosnia ma i vostri nomi non verranno usati».
Mi guarda e scuote la testa, mi rendo conto di non essere stata esauriente. Lui, stira un sorriso paziente, e specifica: «Si, ok ma quindi potete cambiare qualcosa?».
Posso solo dare una risposta vuota di speranza, dicendo qualcos’altro alimenterei più di quanto già non avvenga, quello scarto tra realtà e aspettative che schiaffeggia chi vive in questa incertezza.
Faccio un grande respiro e guardo altrove: «vedi amico, io non sono d’accordo con quello che ti sto per dire ma in realtà tutti, molti, sono al corrente di quello che succede qui. Lo è anche l’Europa». Cazzo, Europa, sembra situata in un altro universo, sembra di parlare di qualcosa lontano migliaia di kilometri da qui e invece da Velika Kladuša al confine con la Croazia ci sono, sì e no, 3km.
«Mi fa arrabbiare che non cambi nulla ma la situazione è proprio questa. E non lo so davvero perché ti sto dicendo questo e se sto rispondendo alla tua domanda. La verità è che a nessuno sembra che importi nulla, a noi che siamo qui, certo, ma i nostri mezzi sono limitati».
Quali mezzi?
Lo dico tutto di un fiato, fingendo di sapere il fatto mio, finita la frase mi fermo, e cerco io, nei suoi occhi, una risposta che mi possa far sentire meno disarmata.
Ci presentiamo, si chiama Mustapha, gli chiedo se fuma, dice di no, rispondo che è meglio. Peccato, almeno ti passava il tempo.
Siamo quasi coetanei, suscita la simpatia di fratello più piccolo, glielo dico: «little-bro’!». Mustapha è di Agadir, prima di migrare lavorava in un hotel come animatore turistico, dice che per abitudine sorride. E’ tornato dal game il giorno prima e zoppica. Racconta che la polizia lo ha spinto nell’acqua fredda e lui, per sbaglio ha trascinato con se un agente.
Grande little-bro’ che ti porti gli sbirri fare i tuffi.
Se non fosse per le ripercussioni che può avere un gesto del genere mi verrebbe da ridere pensando alla scena.
Mustapha parla molto bene l’inglese, esprime il suo stupore riguardo al fatto che i turisti – gli stranieri– in Marocco (per lo più europei) non vengono trattati come loro qui.
Quando gli chiedo perché si è messo in viaggio risponde con una domanda la cui risposta può solo suscitare la consapevolezza di un privilegio: «perché io non posso voler raccontare dei viaggi come facevano con me turisti inglesi e francesi che avevano viaggiato in Kenya, in Marocco, in Europa…? E’ assurdo che le mie prospettive siano limitate. E se io non volessi arrivare a sessant’anni essendo rimasto sempre nello stesso posto?».
Sono d’accordo con te, siamo giovani e viaggiare è bello, ci sono stata ad Agadir, quello che non mi sta bene è perché io si e tu no, ovvietà.
Dice che ci sono possibilità di migrare più facilmente dove, almeno lo scarto religioso, non viene percepito, anche se per lui la religione è poca cosa. Migrare verso paesi del Golfo come Qatar o Arabia Saudita sarebbe comunque inserirsi in segmenti sociali ‘‘sub-alterni’’. Altra gente si raduna.
Sigaretta? Ciao sono Anna, come ti chiami? Ma’ smuka? ‘Ana shuia ‘arabiya, io arabo poco. Faccio domande che ormai sento di circostanza.
Rimango ancora così, in una bolla, oltre la cortina ovattata dei miei pensieri ascolto, offro sigarette e mi presento con chi arriva a metà dei discorsi.
Riemergere
In questa atmosfera polverosa di ghigni segnati, di noi curiosi, ogni sguardo che ci lanciamo mi sembra privo di parole.
Enrico scatta una foto ai ragazzi, alcuni di loro gli chiedono di posare con lui, la macchina fotografica passa in mano a me.
Il progetto di Enrico consiste nel cercare di restituire, attraverso un filtro ad infrarossi applicato alla macchina fotografica quanto le persone intrappolate sul confine siano, rese e percepite come fantasmi.
Gli stessi infrarossi vengono usati per scovare chi attraversa nella notte i boschi di confine, detti la giungla. Una sorta di ironica ambivalenza questa: il filtro della fotocamera ci da la stessa immagine che le pattuglie disumane vedono e costruiscono.
Inquadro, premo la messa a fuoco, scatto.
Sembrate una squadra di calcio.
Dove finiranno i colori e la consistenza di quei sorrisi da spogliatoio non si sa. In qualche cartella di un hard disk, prenderà vita la realtà, l’immagine degli spettri.
Mi richiamano da fuori quell’hangar, è ora di andare via, o almeno di uscire da tutto quel tormento di uomini e fumo. Il sole se ne sta andando. Hamid cerca il mio feedback attraverso domande a cui non so rispondere.
Mi chiede se credo in Dio. Dopo cose così… Gli rispondo di no. Lui ribatte che mi sbaglio, che se si va in campagna e non si incontra l’uomo, lì, si vede la meraviglia di ciò che è Dio.
La sua tesi non mi convince a trasformarmi in immediata credente. Gli esseri umani fanno abbastanza schifo in generale, e gli ‘‘occidentali’’ in questa situazione anche di più, Dio non c’è.
Mi chiede quali soluzioni propongo.
«Cercare di cambiare tutto questo è rischioso e penso che sia molto difficile, Hamid» dico con rassegnazione.
Penso a qualche mese fa quando, alla stazione in Italia, sono stata portata in commissariato per aver chiesto delucidazioni a un poliziotto durante un’aggressiva identificazione a dei ragazzi senegalesi.
«Ma nasciamo per morire, di cosa hai paura!?» mi risponde.
Già di cosa ho paura…?
Secondo Hamid la situazione che stanno vivendo i migranti, come lui, in Bosnia, è tossica: «un giorno tutti noi saremo cittadini europei, e tutti noi odieremo la Croazia ed i croati perché questo è il volto dell’Europa che stiamo conoscendo».
«Per la maggior parte delle organizzazioni e dei Paesi siamo delle cifre, ci chiedono quanta gente c’è, se ci sono più pakistani o algerini… La nostra condizione, peggio di quella di un animale, non ha importanza. Per un po’ di tempo sono passate due ragazze a portarci sacchi a pelo e vestiti, la polizia le ha allontanate. La Croce Rossa viene di rado e quasi a mani vuote. Come potremmo evitare tutto questo? Sarebbe giusto garantire la possibilità di migrare legalmente, almeno».
Come darti torto amico, non ho nulla da obbiettare, questa situazione folle non può che generare traumi e orde di pazzi che, dopo la brutalità della migrazione interminabile, potranno entrare in Europa, in un sistema dove saranno considerati per il trauma che si portano addosso e sbattuti nel lager di un CPR.
La situazione ci sta sfuggendo di mano.
Vorresti aiutare tutti, ma non puoi e non sai come fare. Io non lo so. E non parlo di aiuto inteso come forza d’animo ma proprio materiale.
In quel momento, forse per inconscio istinto di salvatore, ti senti in dovere, vorresti, lasciare qualcosa, compresi soldi. Ma non puoi lasciarli a tutti, scegliere solo qualcuno sull’onda della simpatia è un criterio decisamente discutibile. Lasciare una banconota non è nella mia idea di aiuto né tantomeno lo trovo un modo per migliorare la situazione.
In euro-valuta per giunta, in un ufficio pubblico questi ragazzi non li fanno neanche entrare.
La solidarietà è illegale e negata, c’è l’abbandono e allo stesso tempo la messa in trappola. Quindi si creano sacche di invisibili, che vivono l’inesistenza nell’abbandono, in compagnia di topi, speranze sfumate che diventano lontane e raccolte da qualche curioso giornalista o un timido volontario.
Mi sento scomoda e sprovveduta in questa confusione dove aiutare è, in un certo senso, ‘‘sbagliato’’ ma non farlo lascia quasi ‘‘senso di colpa’’.
Ci richiamiamo a vicenda per salire in macchina, con ancora uomini che si avvicinano ai finestrini. Stiamo ‘‘scappando’’ eppure è come se sentissi la strana tensione di dovermi riempire ancora gli occhi di quello, per confermarne la realtà.
Salutiamo, risalutiamo e salutiamo ancora…buona fortuna, inchallah. Speriamo di vedervi in Italia. Storditi, ripercorriamo la strada a ritroso.
Gli altri cominciano a parlare in macchina. Credo che tutti, in quel momento, abbiamo bisogno di cacciare fuori delle immagini: per appuntarle ma anche per fare in modo che si sedimentino meno violente, e più ordinate, nella memoria; affinchè si ritirino un po’ nello spazio, che diventino razionali, utili e non solo pancia.
Continuano ad affiorare le prospettive di ognuno su quel capannone, pezzi di altre storie raccolte da chi ha parlato con persone diverse.
Mi isolo. Mi bastano, per ora, le storie che ho raccolto io. Digito i dati raccolti nero su bianco nelle note del cellulare, alzo la musica negli auricolari, e scompaio per alcuni minuti.
Intanto ingenuamente penso che vorrei portare in quel campo un pallone da calcio, è una cazzata mi dico, ma ci si passa il tempo, giochi e, per lo meno, non sono soldi.
Percorriamo la strada del ritorno tra i contorni notturni delle testimonianze, vecchie e nuove, di questa frontiera, le case ricostruite dalla diaspora, pompe di benzina, centri commerciali e la fortezza secolare del confine con l’Impero austro-ungarico. Rimugino sulle parole di Hamid e mi frastorna qualcosa: «…un giorno saremo tutti cittadini europei».
L’Europa, terra di ‘‘speranza e pace’’, è piena di materialismo calcolatore, d’incoerenza, assenteismo e reticenza verso il diritto all’umanità. E qui, in questo fabbricone, non c’è nulla oltre ratti e umani, ormai quasi fantasmi, in attesa. Tuttavia se esistesse un oggetto per misurare la speranza, qui, toccherebbe picchi altissimi.
Sono stupita dalla perseveranza di chi prova e riprova a passare questi confini di sangue. Sono attonita davanti al tempo vacuo in cui sono costrette queste persone. Né a destinazione, né alla partenza ma solo in un invisibile “ in mezzo”. La lunga strada fatta, lunga per davvero, e quella da fare, l’eternità. Algeria, Turchia, Grecia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia. Mesi, a volte anni, di tempo e tentativi. Ognuno di questi giorni in sospensione ruba e ricostruisce illusioni lasciando cicatrici su corpo e memoria. Cosa si pensa mentre si cammina di notte per così tanto tempo in luoghi mai visti prima, dentro lingue ed alfabeti diversi, con la luce di aspettative di carta? Come si mantiene viva la speranza, e silente la distruzione di questa, ad ogni respingimento? Cosa rimane della coerenza e della lucidità in questo spazio di nulla? Come riesci a convincerti che uscirai da quel limbo?